Il Festival di Locarno illumina un’epoca poco apprezzata del cinema britannico

Il periodo tra il 1945 e il 1960 era considerato un’epoca di “stagnazione” per il cinema britannico. La retrospettiva del Festival del film di Locarno mira a cambiare questa percezione. Guardando oltre i drammi in costume, le storie di classe o gli adattamenti letterari, questa selezione curata di film britannici del dopoguerra racconta un momento cruciale della storia del Regno Unito.
La sezione retrospettiva del Festival del film di Locarno di quest’anno, intitolata Great Expectations: British Postwar Cinema 1945–1960, offre un’esplorazione approfondita della produzione cinematografica britannica in studio durante un periodo segnato dalla ricostruzione nazionale e dalla trasformazione culturale.
Evita i drammi storici e le narrazioni belliche, mettendo in evidenza film ambientati nel presente che riflettono le complessità della società britannica del dopoguerra. La retrospettiva è curata da Ehsan Khoshbakht, in collaborazione con il British Film Institute National Archive (BFI) e la Cineteca svizzera, con il supporto di STUDIOCANAL.

In un’intervista con Swissinfo, James Bell, curatore senior del BFI National Archive, discute l’importanza di quest’epoca, gli sforzi collaborativi dietro la retrospettiva e la rilevanza di questi film nel panorama cinematografico odierno.
James Bell è entrato nel BFI come curatore senior di fiction nel 2021, dopo molti anni come redattore della rivista Sight and Sound. È stato anche curatore della serie di libri BFI Compendium, i cui titoli includono 39 Steps to the Genius of Hitchcock (2012), Gothic: The Dark Heart of Film (2013) ed Electric Shadows: The History of Chinese Cinema (2014). Fa parte dei comitati editoriali delle serie BFI Classics e British Screen Stories. È anche programmatore regolare delle stagioni cinematografiche Deep Focus al BFI Southbank.
Swissinfo: Come è nato il coinvolgimento del BFI in questo progetto?

James Bell: L’idea è venuta da Ehsan Khoshbakht, il curatore. Ci conosciamo da anni e abbiamo collaborato a vari programmi. Il focus della stagione – l’esplorazione della realtà britannica del dopoguerra attraverso il cinema – è stato un suo concetto. Naturalmente si è rivolto al BFI, poiché possediamo copie di molti dei film e potevamo supportare il programma sia logisticamente che a livello curatoriale.
Ehsan ha lavorato a stretto contatto con me e con la mia collega Jo Botting, una delle massime esperte di cinema britannico di questo periodo. Abbiamo collaborato per affinare la sua lunga lista, valutare ciò che avevamo in archivio, suggerire alternative e garantire che il programma finale riflettesse sia la visione di Ehsan che i punti di forza dell’archivio.
Questa retrospettiva è anche tempestiva perché il BFI National Archive celebra quest’anno il suo 90° anniversario. Sembrava l’occasione perfetta per presentare alcune delle nostre opere chiave a livello internazionale.
Perché pensa che questo particolare quindicennio sia meno discusso a livello internazionale?
Questo periodo si colloca tra due momenti di grande riconoscimento: i film bellici di [Michael] Powell e [Emeric] Pressburger e l’emergere della British New Wave intorno al 1960. Gli anni del dopoguerra sono stati spesso liquidati come un periodo di stagnazione – fu famosa la definizione data da Lindsay Anderson che li chiamò anni di “bonaccia”.
Ci furono anche difficoltà industriali. Aziende come Rank, che erano dominanti, iniziarono a vacillare alla fine degli anni Quaranta. Nonostante ciò, si realizzarono opere molto creative, film formalmente innovativi, radicati socialmente e spesso audaci. Ma non sempre avevano la stessa portata internazionale o audacia stilistica per ottenere un riconoscimento immediato.
Inoltre, i registi britannici del periodo non sono stati sempre analizzati con l’approccio autoriale riservato ai contemporanei americani o europei. Questo sta cambiando, e il programma aiuta a mettere in luce il loro lavoro sotto una nuova prospettiva.
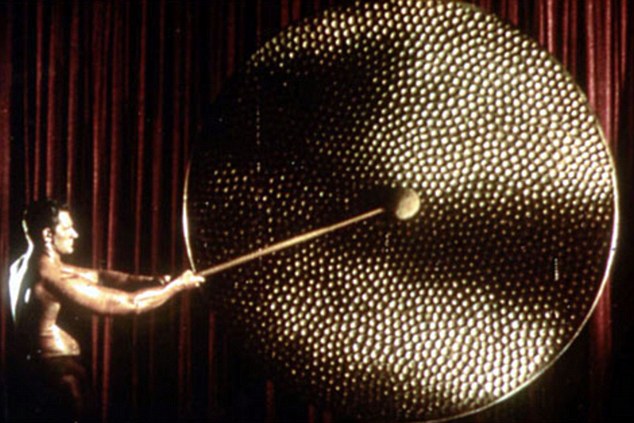
Può spiegare come funzionava il sistema degli studi britannici in quel periodo, e come differiva da Hollywood?
Dopo la guerra, il 1946 fu in realtà l’anno di maggior successo per il cinema britannico in termini di incassi. La società Rank, che gestiva produzione, distribuzione ed esposizione, giocò un ruolo chiave in quel successo. Ma alla fine degli anni Quaranta, Rank era in difficoltà. John Davis subentrò a J. Arthur Rank e spostò l’attenzione dalla libertà artistica al controllo finanziario, cambiando radicalmente l’atmosfera.
Il cinema britannico mancava del volume e della struttura verticale di Hollywood. Rank era il protagonista, ma anche British Lion ed Ealing Studios vissero il loro momento di gloria intorno al 1949-50. A metà degli anni Cinquanta, Hammer Films ebbe un grande successo, soprattutto negli Stati Uniti, con le sue produzioni horror.
Allo stesso tempo, le produzioni indipendenti divennero più comuni, spesso affidandosi a queste grandi aziende per la distribuzione. L’ambiente creativo cambiò con la leadership, le finanze e le richieste del pubblico.
Questi film venivano visti anche fuori dalla Gran Bretagna?
Alcuni sì. Le commedie di Ealing erano popolari negli Stati Uniti, e i film horror di Hammer furono grandi successi internazionali. Ma molti dei film più realistici e noir non funzionavano altrettanto bene. Spesso parlavano specificamente all’esperienza britannica, il che poteva limitarne la portata internazionale.
Detto ciò, si possono vedere le prime tracce della British New Wave in questo periodo: gli “angry young men” della fine degli anni Cinquanta, così come il movimento Free Cinema guidato da Lindsay Anderson.
Un aspetto interessante del programma è l’enfasi sui film ambientati nel presente. All’inizio pensavo fosse una scelta un po’ restrittiva, ma a posteriori ha molto senso.
Assolutamente. L’effetto ottenuto, in modo potente, è sfidare alcune delle percezioni internazionali prevalenti sul cinema britannico: cioè che siano tutti drammi in costume, storie di classe o adattamenti letterari.
Sì, l’idea che il cinema britannico sia dominato da drammi in costume o film ambientati in epoche storiche è ancora molto diffusa, soprattutto fuori dal Regno Unito.
Esatto. E sebbene quei film esistano e abbiano il loro posto – si pensi agli adattamenti shakespeariani di Laurence Olivier o a Great Expectations di David Lean – questo programma li evita deliberatamente. Si concentra invece su film contemporanei al loro tempo, che catturano la Gran Bretagna del dopoguerra com’era.
Questo aiuta a cambiare la narrazione, vero?
Esattamente. I primi melodrammi Gainsborough, ad esempio, spesso considerati “film per donne”, erano estremamente popolari ma talvolta criticamente sottovalutati. Sebbene la maggior parte di essi fosse prodotta durante la guerra, questo programma va oltre. Non appoggiandosi ai cliché narrativi, apre lo spazio per riconsiderare cosa rappresentasse davvero il cinema britannico di quell’epoca.
Sono inclusi anche documentari e cortometraggi nel programma?
Sì, Ehsan voleva includere alcuni cortometraggi e documentari accanto ai lungometraggi. Un esempio è The Elephant Will Never Forget (1953), un corto malinconico e bellissimo sull’ultimo viaggio in tram attraverso Londra. Sebbene la maggior parte dei film siano narrativi, molti contengono forti elementi di realismo, specialmente nell’uso di paesaggi urbani. In questo senso, il confine tra finzione e documentario spesso si sfuma.
Martin Scorsese ha recentemente curato un programma di film britannici al BFICollegamento esterno. C’è qualche sovrapposizione con questa retrospettiva?
Sì, c’è una certa sovrapposizione. Scorsese ha compilato una lista di film britannici meno conosciuti su richiesta di Edgar Wright. Abbiamo costruito una stagione attorno a quella lista al BFI. Quella selezione, come quella di Ehsan, evidenzia un crescente interesse nel rivalutare questo periodo. È entusiasmante vedere questi film essere nuovamente apprezzati, sia nel Regno Unito che a livello internazionale.
Alcuni dei registi di quest’epoca, come Cy Endfield o Joseph Losey, erano emigrati americani o inseriti nella lista nera. Che impatto ha avuto questo?
Figure come Endfield e Losey hanno portato una prospettiva nuova, da outsider, sulla vita britannica, che si percepisce chiaramente nelle loro opere. Oltre a ciò, molti film di questo periodo avevano troupe internazionali: direttori della fotografia europei, ad esempio, che apportavano una sensibilità visiva diversa. Otto Heller, che ha fotografato Peeping Tom (1960) e Temptation Harbour (1947), aveva un background nel cinema tedesco, e si nota nell’estetica noir. Sebbene questi film siano distintamente britannici nei contenuti, un sottotesto internazionale attraversa molti di essi.

Ha qualche raccomandazione personale riguardo ai gioielli nascosti dal programma?
Temptation Harbour è una pellicola che vorrei evidenziare: un noir costiero diretto da Lance Comfort e fotografato da Otto Heller. È atmosferico e realizzato magnificamente. Daughter of Darkness (1948) è un altro film di Lance Comfort, caratterizzato da intensità psicologica e uno stile unico.
The Yellow Balloon (1953) di J. Lee Thompson è molto forte, soprattutto nel modo in cui ritrae il paesaggio urbano londinese del dopoguerra. Hell Drivers è fantastico. Pool of London (1951), di Basil Dearden, è un altro film notevole per l’uso delle location e del contesto sociale.
Questo programma mira a rivedere o ampliare la comprensione della storia del cinema britannico?
Questo è certamente l’obiettivo. A livello internazionale, quest’epoca è stata sottovalutata. Se questa retrospettiva incoraggia programmatori, critici o pubblico a rivalutarla o a esplorare di più su singoli registi e le loro opere, allora è un risultato significativo.
I semi della British New Wave sono stati piantati in questo periodo. Comprendere questi film aiuta a dare senso a ciò che è venuto dopo e a ridefinire ciò di cui il cinema britannico era capace durante quegli anni apparentemente “tranquilli”.

A cura di Catherine Hickley/gw
Tradotto con il supporto dell’IA/MaMi

In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.